Secondo il filologo Igor Sibaldi, il “patrono d’Italia” non si chiamava neppure Francesco, ma Giovanni: era di origine provenzale, e dall’appellativo “il francese” nacque poi il nome canonico del futuro “poverello di Assisi”. Nel saggio “San Francesco, le verità nascoste” (Melchisedek) Gian Marco Bragadin denuncia «l’ipocrita ricostruzione che lo ha trasformato nel più fedele e mansueto servitore della Chiesa, nel medioevo e oltre, fino ai giorni d’oggi». Un falso storico: «Moltissimi documenti, scritti, memorie su Francesco (e probabilmente anche su Chiara) sono stati dati alle fiamme per non propagare un ritratto non idoneo a farne un obbediente santo della Chiesa cattolica». E non a caso, rivela la storica medievale Chiara Mercuri, autrice di “Francesco d’Assisi, la storia negata” (Laterza), per la biografia ufficiale di Francesco, ovviamente postuma, fu incaricato Bonaventura da Bagnoregio: un frate erudito, ma che non aveva mai conosciuto Francesco. Venne così effettuata una vera e propria opera di demolizione, spiega Paolo Franceschetti, autore di un saggio (“Alla ricerca di Dio”) che traccia ponti spirituali tra le diverse religioni. Specialità di cui era un campione proprio Francesco d’Assisi: vicino ai Catari, ai Templari e ai Sufi. Al punto da raggiunge il Sultano, in Egitto, nel settembre del 1219.
Uno dei più straordinari gesti di pace nella storia del dialogo tra Islam e Cristianesimo, scrive il blog dedicato al santo di Assisi, è rappresentato dall’incontro tra Francesco e il sultano Malik al Kamil, nipote del Saladino. «Quello storico colloquio,  avvenuto a Damietta, a pochi chilometri di distanza dal Cairo, è ancora oggi così significativo e attuale per le sue conseguenze nel dialogo interreligioso e per la pace mondiale, tanto da rimanere, pur a distanza di molti secoli, l’avvenimento esclusivo che indica la rotta da cui partire nella ricerca di intesa e armonia tra Oriente e Occidente». Un libro di padre Gwenolè Jeusset, francescano e componente della “Fraternità Internazionale” di Istanbul, rivela l’importanza di quell’evento, sulle rive del Nilo. Nel suo saggio (“San Francesco e l’Islam: l’attualità di un incontro possibile”, edito da Terra Santa) si scopre che Francesco d’Assisi voleva andare a tutti i costi tra i musulmani, tanto che per tre volte fece i suoi tentativi, senza scoraggiarsi dei fallimenti. Il terzo tentativo fu quello buono, per l’incontro con Malik, caratterizzato da «cortesia, rispetto e dialogo», proprio mentre sulle due rive del Mediterraneo scorreva l’odio. «A Damietta, il Vangelo si incontrò con il Corano e il Corano con il Vangelo: Francesco non ebbe paura di Maometto e il Sultano non ebbe paura di Cristo».
avvenuto a Damietta, a pochi chilometri di distanza dal Cairo, è ancora oggi così significativo e attuale per le sue conseguenze nel dialogo interreligioso e per la pace mondiale, tanto da rimanere, pur a distanza di molti secoli, l’avvenimento esclusivo che indica la rotta da cui partire nella ricerca di intesa e armonia tra Oriente e Occidente». Un libro di padre Gwenolè Jeusset, francescano e componente della “Fraternità Internazionale” di Istanbul, rivela l’importanza di quell’evento, sulle rive del Nilo. Nel suo saggio (“San Francesco e l’Islam: l’attualità di un incontro possibile”, edito da Terra Santa) si scopre che Francesco d’Assisi voleva andare a tutti i costi tra i musulmani, tanto che per tre volte fece i suoi tentativi, senza scoraggiarsi dei fallimenti. Il terzo tentativo fu quello buono, per l’incontro con Malik, caratterizzato da «cortesia, rispetto e dialogo», proprio mentre sulle due rive del Mediterraneo scorreva l’odio. «A Damietta, il Vangelo si incontrò con il Corano e il Corano con il Vangelo: Francesco non ebbe paura di Maometto e il Sultano non ebbe paura di Cristo».
Quali sono, dunque, le verità nascoste all’ombra del personaggio di Assisi? In pratica, tutto quello che si è raccontato di lui è interamente falso, dichiara Bragadin all’agenzia “AdnKronos”: Francesco d’Assisi è stato «un guerriero che ha combattuto, è stato imprigionato, più volte ha tentato di andare alla Crociata per diventare un valoroso cavaliere». Inoltre «si è innamorato dell’ideale dei Templari, al punto che il suo ordine è modellato su quello templare». Non solo: «Templari erano alcuni suoi frati». Poi c’è l’ascendenza catara ereditata dalla madre, originaria del Midi francese: e proprio dai Catari, sostiene Bragadin, Francesco ha preso il concetto di servizio ai poveri e rifiuto della proprietà. «Ma non si deve dire, perché la Chiesa all’epoca lanciò una crociata per distruggere i Catari, con massacri orribili». Proprio la Crociata Albigese, scatenata nel 1209 e protrattasi per vent’anni, segnò la fine dell’autonomia feudale dell’Occitania: dalla conquista dei castelli del Sud, dove l’aristocrazia occitanica difendeva la libertà religiosa degli eretici, si giunse all’annessione violenta di Provenza, Linguadoca, 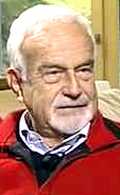 Aquitania, Guiana e Guascogna, da cui nacque il paese che, da allora, cominciò a chiamarsi Francia (e a imporre la sua Lingua d’Oil, il francese appunto, spegnendo la Lingua d’Oc dei Trovatori, vero e proprio cardine dell’identità nazionale occitanica).
Aquitania, Guiana e Guascogna, da cui nacque il paese che, da allora, cominciò a chiamarsi Francia (e a imporre la sua Lingua d’Oil, il francese appunto, spegnendo la Lingua d’Oc dei Trovatori, vero e proprio cardine dell’identità nazionale occitanica).
«Francesco – prosegue Bragadin – ha tentato in tutti i modi il contatto con i musulmani: non per convertirli (lui non giudicava nessuno, mostrava il suo esempio di vita), ma per trovare i punti di unione tra le religioni, per raggiungere una pace duratura. Ancora oggi, da allora, i francescani hanno la cura del Santo Sepolcro a Gerusalemme, dono del Sultano a Francesco e Frate Elia». Tutte queste verità furono nascoste, aggiunge il saggista, «perché Francesco ha vissuto una esistenza da eretico, sempre sul filo di finire al rogo». Vista però la sua enorme popolarità, dovuta al rivoluzionario messaggio d’amore di cui era portatore, «si è fatta conoscere solo una parte della sua vita, nascondendo tutto ciò che lo riguardava, insieme alla sua amata compagna Chiara, e che poteva essere disdicevole per l’istituzione ecclesiastica». Francesco d’Assisi un religioso? Ebbene, no: «Francesco ha voluto restare sempre un laico, ma non lo sa nessuno», rivela Bragadin. Era un tizio che «predicava il Vangelo nelle piazze, alle feste, nei mercati: come poteva, la rigida Chiesa del tempo, ammettere che un laico parlasse di Cristo alla gente? Poteva predicare agli uccelli o ai lupi, non alla gente. E invece Francesco non ha fatto altro per tutta la vita, perfino quando era malato».
Non a caso, la storica Chiara Frugoni, in varie interviste, si domanda perché esistano migliaia di quadri e affreschi su Francesco, e neanche uno in cui predica. E la ragione è la seguente: non si voleva tramandare l’immagine di un laico che parlasse di Cristo. «Morto Francesco nel 1226, allontanati i suoi vecchi confratelli, segregata Chiara nel convento – ricostruisce Bragadin, attingendo a una serie di fonti fra cui molti scritti di Tommaso da Celano – sono cominciate tutte le iniziative per cancellarne la vera storia e dare ai fedeli una immagine edulcorata di mansueto, docile soldatino della Chiesa cattolica». Come? «Nel 1260, al Capitolo (annuale riunione dei francescani) che si teneva a Narbonne, in Francia, a frate Bonaventura viene affidato il compito di scrivere una nuova biografia di Francesco, che viene approvata a Pisa nel 1263, durante il Capitolo successivo». E non è tutto: «Nel 1266 il Capitolo, riunito a Parigi, giunge a decretare la distruzione di tutte le biografie precedenti alla “Legenda Maior”, con la scusa che biografie diverse avrebbero condotto l’ordine monastico verso una divisione». Una decisione – commenta Bragadin – compiuta così bene da far sparire dalla faccia della terra anche gli  scritti di Francesco e quelli di Chiara, le lettere, le testimonianze. Addirittura, vengono rimossi dalle chiese anche gli affreschi e le immagini raffiguranti Francesco e Chiara.
scritti di Francesco e quelli di Chiara, le lettere, le testimonianze. Addirittura, vengono rimossi dalle chiese anche gli affreschi e le immagini raffiguranti Francesco e Chiara.
“La Vita Prima” del Celano – dice l’autore – viene ritrovata miracolosamente solo nel 1768, a più di cinque secoli dalla morte di Francesco. “La Vita Seconda”, un manoscritto molto difettoso, viene scoperto nel 1806. Il “Trattato dei Miracoli” fu acquistato casualmente a un’asta pubblica nel 1900. Così, osserva Bragadin, si è avuto tutto il tempo di costruire una storia artificiale e falsa. «Nell’agiografia di Bonaventura – lo ammettono tutti gli storici ufficiali – si inventano anche false vicende, per far corrispondere la figura di Francesco a quanto si voleva tramandare, funzionale cioè alla posizione che voleva prendere l’ordine francescano. E si trascura del tutto, naturalmente, la figura di Chiara e le sue vicende, quasi le clarisse non facessero parte del movimento». Anche lo storico cattolico Franco Cardini ammette che «di Chiara si sa poco». Il presbitero Ernesto Balducci, scrittore e cattolico “eretico”, disse che frate Bonaventura (poi vescovo, cardinale, e infine santo) ordinò di bruciare tutti gli scritti su Francesco. «Sembra un ordine da Cremlino», annota Bragadin. Sa quel momento, «la verità su Francesco non sarà più quella della sua vita privata, ma una verità imposta dalla Chiesa».
Lo stesso Bragadin racconta di aver visitato Assisi più di cento volte, nel corso di ricerche a tutto campo durate 25 anni. Il tempo di allacciare rapporti «con tutti coloro che potevano raccontare le verità nascoste, che sono tantissime». Al vaglio del saggista anche le informazioni provenienti da frati o storici “non allineati” come Paul Sabatier, che ipotizza tutto quello che poi Bragadin ha messo per iscritto: «E’ il caso, per esempio, dei colloqui con vecchi frati amici che se ne fregavano, data l’età, di mantenere segreti sui due santi d’Assisi e sul loro immenso “amore cosmico”, che nell’ordine francescano si tramandava per via orale». Qualcosa, sul vero Francesco, l’aveva raccontata Dario Fo in teatro. Nelle stesse “Vite” del Celano, ammette Bragadin, si raccontano storie che sono al limite della decenza: Francesco parlava con tutti gli animali, si confidava con i lupi, abbracciava i maiali, si spogliava nudo in chiesa, lavorava con i muratori e si faceva beffe delle autorità. «No, un santo così non  lo si può accettare. Perciò nasce la decisione di ricostruire da capo un santo completamente diverso». Vescovi e cardinali riuniti non potevano tollerare che nella storia di un santo ci fosse un estremista, un barricadero capace di incitare la folla contro i potenti.
lo si può accettare. Perciò nasce la decisione di ricostruire da capo un santo completamente diverso». Vescovi e cardinali riuniti non potevano tollerare che nella storia di un santo ci fosse un estremista, un barricadero capace di incitare la folla contro i potenti.
L’autore di “San Francesco, le verità nascoste” parla anche dell’amore di Francesco per i Sufi, i mistici islamici che – nel loro sincretismo – sembrano incorporare l’antica spiritualità dell’Oriente, a partire dal Mazdeismo di Zoroastro (la cui eco compare nel racconto evangelico dell’adorazione dei Magi), per poi abbracciare il buddhismo prima ancora che Maometto, mantenendo sempre la porta aperta all’Occidente cristiano. Confraternita esoterica a numero chiuso, da cui poi la massoneria prenderà in prestito lo schema iniziatico, si ritiene che proprio i Sufi (come l’italo-afghano Gabriele Mandel, maestro di Franco Battiato) abbiano sempre avuto un ruolo decisivo nel mitigare il potere, avvicinare mondi lontani e coltivare la pace. Il legame con Francesco d’Assisi è dimostrato dal rosario Sufi trovato nella sua tomba. Senza contare il pellegrinaggio in Terrasanta: fonti storiche ufficiali negano che Francesco, dopo i massacri dei Crociati a Damietta nel 1220, si sia recato a Gerusalemme, nonostante avesse un permesso speciale del Sultano. Ma come possiamo credere – si domanda Bragadin – che Francesco, a pochi passi dalla meta, dopo quasi un anno trascorso in Medio Oriente, abbia rinunciato a visitare i luoghi “santi” del suo Gesù? E’ Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, a confermarlo: «San Francesco ha visitato il Santo Sepolcro, ci sono elementi certi: ha gettato un seme che avrebbe portato molto frutto».
E se lo dice Ratzinger, «che sa dove stanno le prove», possiamo stare tranquilli, chiosa Bragadin, che ricorda – fra l’altro – che una buona metà del “Cantico di Frate Sole” sembra tratto dai versi del sommo poeta musulmano, l’afghano Rumi, cioè l’eminente Sufi che sempre nel 1200 fondò la prima scuola iniziatica dei Dervisci Rotanti. La tomba di San Francesco, scrive Paolo Franceschetti nel blog “Petali di Loto”, venne ritrovata solo nel 1818, ben 600 anni dopo la tumulazione. E attenzione: «Straordinariamente, non contiene alcun simbolo cristiano, ma al contrario, oggetti che simbolicamente richiamerebbero altro, come il corno e le bacchette d’avorio che richiamano i Sufi». Lo stesso saio dei francescani ha molto in comune con quello dei Sufi, mentre la spiritualità francescana e il pensiero di Francesco sono in perfetta armonia con quella dei Catari, ma  anche dei Templari. «Francesco firmava i suoi scritti con la Tau e non col segno della croce», aggiunge Franceschetti. «E segnava col Tau, come a benedirli, molti dei luoghi in cui sostava».
anche dei Templari. «Francesco firmava i suoi scritti con la Tau e non col segno della croce», aggiunge Franceschetti. «E segnava col Tau, come a benedirli, molti dei luoghi in cui sostava».
Nell’opera di demolizione post-francescana, dice sempre Franceschetti (che animerà anche visite guidate ad Assisi, alla ricerca del vero Francesco) due figure sono state occultate in modo palese: quella di Frate Elia (Elia da Cortona), che Francesco designò espressamente come suo successore, e che rimase molto legato all’altra figura rimossa dalla vita ufficiale di Francesco, cioè Santa Chiara: lei stessa teneva in considerazione Elia più del Papa stesso. Chi era, frate Elia? «Era un alchimista, consigliere politico dell’imperatore Federico II, in stretto contatto coi Templari». Cosa legava un alchimista, per di più templare, alla spiritualità francescana? «I viaggi di San Francesco, Frate Elia e Federico II in Terrasanta – spiega Franceschetti – ebbero come risultato una pace senza spargimento di sangue: il sultano Al Malik, parente del Saladino, dette il permesso ai pellegrini cristiani di andare a Gerusalemme senza pericolo. In altre parole, ottennero come risultato quello che era lo scopo delle Crociate; e lo ottennero senza spargimento di sangue».
Per inciso, rileva sempre Franceschetti, frate Elia è anche il monaco che occultò la tomba di Francesco «per ragioni che ancora oggi non si riescono a spiegare». Insieme ai simbologi Gianfranco Carpeoro e Michele Proclamato, Franceschetti conduce conferenze per far luce sulla vera identità della confraternita iniziatica che nel ‘600 prese il nome di Rosa+Croce. Un network sapienzale costretto a vivere in clandestinità dai tempi di Giordano Bruno, con radici in realtà risalenti a Gioacchino da Fiore, Dante Alighieri e molti altri. Numerosi personaggi rosacrociani, scrive Franceschetti, militavano nel cosiddetto Terzo Ordine Francescano: Michelangelo, lo stesso Dante, Raffaello, Giotto. «Cosa lega i Rosacroce a San Francesco e ai francescani in generale?». Presto detto: «La madre di Francesco era catara. E a quel tempo in Umbria e nel Lazio c’erano molte comunità catare. Non a caso la spiritualità francescana era molto più vicina a quella catara che alla Chiesa cattolica, perlomeno negli aspetti esteriori». Catari e, naturalmente, Cavalieri del Tempio: «Uno dei primi seguaci di Francesco, Angelo Tancredi, era un templare. E, data la massiccia presenza templare ad Assisi, ai tempi di San Francesco, si può supporre agevolmente il contatto che doveva esserci tra la spiritualità templare e quella francescana. Contatto confermato, tra i tanti indizi, dal fatto che nella  basilica di San Francesco, ad Assisi, è tumulato Giovanni di Brienne, templare, che aveva il titolo di Re di Gerusalemme ed era suocero di Federico II».
basilica di San Francesco, ad Assisi, è tumulato Giovanni di Brienne, templare, che aveva il titolo di Re di Gerusalemme ed era suocero di Federico II».
A partire dalla missione che frate Elia e Francesco condussero in Palestina, ai francescani venne attribuito il titolo di “Custodi della Terra Santa”: furono autorizzati dal Sultano stesso a soggiornare permanentemente in quei luoghi a partire dal 1229, anno in cui Federico II concluse la sua crociata in modo pacifico, dialogando col sultano Al Malik (lo stesso incontrato da Francesco nel 1219 a Damietta, in Egitto). Per Franceschetti, il futuro San Francesco era un vero iniziato, e il suo ordine «era solo una delle molteplici forme in cui i cosiddetti Giovanniti si erano costituiti per vivere secondo il pensiero e la dottrina di Cristo», che ritenevano “cifrata”, esotericamente, nel Vangelo di Giovanni. La sua spiritualità? «Era quella universale, di tutte le religioni». Francesco d’Assisi «non era quindi un cattolico, ma un giovannita», cioè un mistico il cui credo affondava nel pensiero gnostico che aveva pervaso il Catarismo, i “Fidelis in Amore” travestiti da letterati del Dolce Stil Novo, e con loro i futuri Rosa+Croce, i Templari, gli stessi Sufi e gli Chassidim ebraici, impervi esegeti della Cabala. «Non a caso Papa Giovanni Paolo II organizzò proprio ad Assisi l’incontro con i rappresentanti di tutte le religioni», chiosa Franceschetti, il cui saggio sulle fedi religiose del pianeta punta a individuare punti essenziali di contatto, sul piano spirituale, anche con il buddhismo e con la matrice da cui proviene, cioè l’induismo. Era tutto questo, il presunto Francesco (o forse Giovanni) d’Assisi, ovvero “il francese” di cui il Vaticano si affrettò a cancellare la vera storia?